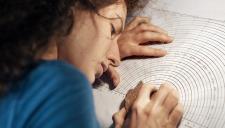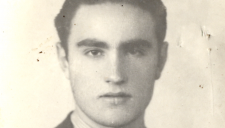Pubblichiamo per intero l’intervento di Giovanni Maria Flick per i Venerdì del direttore della Normale. A sessant’anni dalla promulgazione, la Costituzione italiana sorprende per la propria freschezza e lungimiranza.Il Vicepresidente della Corte costituzionale riafferma i principi fondamentali della carta elaborata dai padri costituenti, che continuano ad essere valori da cui l’Italia deve ripartire.
di Giovanni Maria Flick
1. «La Costituzione rappresenta più che mai – nella sua comprovata validità – un patrimonio comune»: nessuna forza politica può reclamarne in esclusiva l’eredità, «possono solo, tutte insieme, richiamarsi ai suoi valori e alle sue regole, e insieme affrontare i problemi di ogni sua specifica, possibile revisione». Così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il 23 gennaio scorso, nell’aula di Montecitorio, davanti al Parlamento in seduta comune e alla presenza degli organi costituzionali e dei rappresentanti delle Regioni, ha celebrato il 60° anniversario della Costituzione repubblicana.
A quell’affermazione intendo ancorare queste riflessioni, che già nel titolo racchiudono ad un tempo la premessa e la conclusione. Le origini e il contenuto della Costituzione – fra loro inscidibilmente connessi – rendono ragione della sua attualità e della sua capacità di continuare a lungo a costituire il punto di riferimento della nostra convivenza, nonostante il profondo mutamento del contesto sociale, politico ed economico, rispetto a quelle origini; ferma restando la necessità di qualche cauto ritocco a quel contenuto, nella sua seconda parte. E, d’altronde, prima di interrogarsi sull’obsolescenza della Costituzione – come oggi è di moda – occorrebbe chiedersi quanto di essa resta ancora da attuare, a sessanta anni dalla sua entrata in vigore.
L’appello al “patrimonio comune” non è retorica, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo: innanzitutto perché il Presidente della Repubblica è il garante dell’unità del Paese, e Napolitano – pur in lineare continuità con i suoi predecessori – interpreta in modo straordinario questa funzione, con la ben nota pacatezza dei modi, ma con altrettanta passione e risolutezza nei contenuti e negli inviti alla responsabilità, che non si stanca di rivolgere alle forze politiche. Le quali purtroppo – lo dico come cittadino – faticano a trovare metodi condivisi per riformare insieme le regole della rappresentanza e per il funzionamento delle istituzioni, senza naturalmente dover rinunciare alla diversità dei programmi di governo e al pluralismo delle idee.
E tuttavia non compiremo alcun passo avanti e rischieremo di doverci rifugiare nello sterile terreno della retorica, se non sapremo partire dalla Costituzione, senza però allontanarcene: senza, cioè, riconoscere che nonostante i decenni e qualche ruga, la Carta è più che mai viva, soprattutto ma non soltanto nella sua prima parte. E se questa è quasi inviolabile, quanto i princìpi che afferma, la seconda parte va maneggiata con estrema cura, perché le garanzie e i contrappesi fra i poteri e le istituzioni non costituiscono soltanto un insieme di regole, liberamente modificabili a colpi di maggioranza e soggette solo al criterio dell’efficienza. Pur nella diversità dei sistemi possibili, da quelle regole dipende il concreto, quotidiano realizzarsi dei princìpi e del metodo democratici. D’altra parte non sarebbe neppure giusto attribuire soltanto ai limiti, veri o presunti, dell’assetto ordinamentale – pur non immodificabile – disegnato dalla Costituzione, le difficoltà fisiologiche e patologiche derivanti le une dal confronto politico, legittimo; le altre dalla rissosità tra le forze politiche, di cui sarebbe invece auspicabile il superamento. Le regole sono essenziali, come è necessario il loro adeguamento; ma le regole da sole non bastano a supplire al deficit della politica.
La profondità delle radici e la nobiltà dell’origine della Costituzione – che, con il suo contenuto, contribuiscono a farne un “patrimonio comune” – risiedono in una duplice prospettiva. Da un lato, in negativo, la frattura con il passato, il riscatto da ideologie perverse e la memoria delle loro degenerazioni e distruzioni ideali, materiali e soprattutto umane (causate dalla compressione delle libertà civili e politiche; dall’abolizione del pluralismo politico e dal controllo autoritario di quello sociale; dal totalitarismo statale e dalla concentrazione del potere in un unico vertice; dal bellicismo nei rapporti con gli altri Stati; dall’esaltazione e dalla discriminazione della razza). Da un altro lato, in positivo, il suggello di un nuovo patto, civile, politico e sociale: il patto al quale si riferiva Giuseppe Mazzini, quando affermava che il futuro di una nazione non può che essere proferito da una Costituente e non può che incarnarsi in un patto nazionale.
2. A differenza delle Carte fondamentali di altri Paesi, la nostra Costituzione è il frutto di un dibattito autentico, di altissimo spessore politico e giuridico, di cui furono protagonisti i partiti e i membri dell’Assemblea Costituente. E vorrei aggiungere che la saldezza del patto che l’ha generata sta anche in un mix di coraggio e di generosità: se la rottura con il passato autoritario fu netta – nell’opzione non semplicemente afascista, ma chiaramente antifascista – la scelta, altrettanto netta, per la forma repubblicana dello Stato (al punto che si tratta dell’unico articolo anche formalmente immodificabile, per espressa previsione costituzionale) non comportò l’umiliazione di quella larga parte del Paese che, pur rompendo con il passato regime, aveva confermato la sua opzione monarchica al referendum istituzionale del 1946. Tanto che il Capo provvisorio dello Stato eletto dall’Assemblea costituente, e che avrebbe promulgato la Costituzione repubblicana, fu Enrico De Nicola: uno statista liberale ma anche monarchico, Presidente della Camera dei deputati del Regno d’Italia fino alla svolta autoritaria del fascismo e poi Presidente del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nel primo anno di vita di quest’ultima.
L’organizzazione statale contrapposta a quella del regime fascista – e in grado di contrastare ogni tentazione autoritaria – rappresentò il momento unificante tra le volontà, anche profondamente distanti sul piano ideologico, delle forze politiche che il 22 dicembre 1947 approvarono la Carta costituzionale con soli 62 voti contrari fra i 515 padri Costituenti presenti e votanti. Aspetto, questo, sottolineato già nel febbraio precedente, nella relazione del Presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini, al progetto poi discusso per dieci mesi dall’Assemblea Costituente: «Vi è un punto che non si deve mai perdere di vista in nessun momento, in nessun articolo della Costituzione: il pericolo di aprire l’adito a regimi autoritari e antidemocratici».
Il merito dei padri Costituenti sta proprio in questa capacità di pacificare il Paese e voltare pagina, rinunciando alla tentazione dell’oblio e anzi fondando la sua rinascita sulla perenne memoria delle sofferenze degli uomini, prima ancora che sui valori della Resistenza. Ciò che espresse uno tra i più degni e autorevoli componenti di quell’assemblea, Piero Calamandrei: «Nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti o nelle steppe dove caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto, ivi è nata la nostra Costituzione».
Il significato profondo di memoria (la cui radice è molto prossima a quella di testimonianza) non è quello della semplice evocazione, ma quello della rinnovazione. Al credente basti ricordare le parole dell’ultima cena, “fate questo in memoria di me”, dalle quali scaturisce non un ricordo, ma una presenza. Ed è importante, di questi tempi, richiamare la memoria: perché – come osservava recentemente Arrigo Levi – non è vero che in Italia vi sia un’overdose di memoria e di commemorazione, ma c’è, semmai, una memoria troppo corta e soltanto troppo formale; od ancora – come diceva già Leonardo Sciascia – l’Italia « è un paese senza memoria e verità» .
Il richiamo della memoria e, attraverso essa, il rifiuto del passato – in cui si articola il primo nucleo essenziale e condiviso della nostra Costituzione – consente di cogliere un primo aspetto della perdurante attualità di quest’ultima; e di sfuggire quindi al rischio di una celebrazione soltanto retorica. Infatti, la memoria guarda al futuro attraverso l’esperienza (e la sofferenza) del passato, per impedire il riemergere o almeno per contrastare l’intolleranza, il rifiuto delle diversità, l’antisemitismo, la violenza xenofoba, il fanatismo religioso, la violazione dei diritti umani a cominciare da quello alla vita: fantasmi e ricordi inquietanti di quel passato; ma al tempo stesso interrogativi più che mai attuali ed egualmente inquietanti su scala ben più ampia, in una dimensione globale, all’esordio del nuovo secolo.
Dunque – di fronte alla memoria del passato e alla minaccia del presente e del futuro – voltar pagina sì, riconciliarsi anche; ma senza sfumare le differenze e relativizzare torti e ragioni, senza confusioni tra parte giusta e parte sbagliata. E quando non si ha il coraggio o almeno la fortuna di fare questi conti, ci si illude di dimenticare un passato che in realtà non si supera mai, come dimostrano le polemiche dei giorni scorsi, in occasione della legge spagnola sulla memoria: una legge, sul merito della quale non sta a me ovviamente entrare; ma che certamente rimuove il trentennale accantonamento dopo la morte di Franco, reso probabilmente necessario per la pacifica transizione alla democrazia e il ritorno a una monarchia che ha acquisito tanti meriti, ma evidentemente insufficienti a far voltar pagina al Paese.
Solo tenendo vive le radici della Costituzione – come la vita e le parole dei Costituenti stanno lì a ricordarci – sarà possibile riconoscere le ragioni degli altri, rispettare tutte le memorie e favorire la convivenza tra i popoli, soprattutto attraverso le nuove generazioni, come dimostra lo straordinario cammino dell’Unione europea, ben più forte delle momentanee battute d’arresto dei governi e delle incomprensioni delle opinioni pubbliche, talvolta mal orientate dalle forze politiche (il Trattato di Lisbona ha superato in qualche modo il fallimento della ratifica del Trattato costituzionale del 2004; ma non possiamo dimenticare che la prevalenza del no nel referendum francese fu preparata dalla precisa indicazione di voto di alcuni partiti politici).
3. Se, dopo aver richiamato la prospettiva negativa, di rifiuto del passato, si guarda a quella positiva – il patto civile, politico e sociale, nella prima parte della Costituzione – risulta evidente la confluenza in essa delle tre grandi correnti ideali, rappresentate da più dei tre quarti dei Costituenti: i cattolico-democratici riuniti nella Democrazia cristiana, partito di maggioranza relativa; i deputati di ispirazione socialista e comunista, senza tralasciare la componente laica e radicale del Partito d’azione; l’area liberal-democratica, minoritaria ma tutt’altro che assente, con esponenti di primissimo piano come Benedetto Croce e il futuro presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Una confluenza di idealità e di pensieri che avrebbe trovato simbolica sintesi nelle tre firme poste in calce alla Costituzione: quella del Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, espressione della tradizione liberale; quella del Presidente dell’Assemblea costituente, Umberto Terracini, cofondatore del Partito comunista italiano; quella del Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, successore di Luigi Sturzo alla segreteria del Partito popolare, prima dello scioglimento dei partiti.
È stato a lungo sottolineato il carattere compromissorio delle disposizioni della prima parte della nostra Costituzione: lungi dall’esprimere una connotazione negativa, si tratta di un elemento essenziale e positivo della nozione stessa di patto. Non già un compromesso al ribasso, inteso soltanto come reciproca rinunzia a una parte delle proprie convinzioni e pretese, pur di trovare un accordo a qualsiasi prezzo; ma un compromesso alto, non logorato dal tempo, punto di incontro e di sintesi del patrimonio migliore di ciascuno, che ha saputo selezionare le più nobili e profonde istanze ideali delle tre correnti di pensiero.
Quel compromesso garantisce, infatti, che la Costituzione sia ‘di tutti’, sì che ad essa le diverse forze, pur rimanendo antagoniste, potevano e possono appellarsi ad egual titolo; piuttosto che essere una Costituzione ‘di maggioranza’, espressione, dunque, di forze vincenti che vi si riconoscono pienamente, al contrario di altre, perdenti, che non potrebbero riconoscervisi. Perché – come osservava recentemente Giuliano Amato – il principio maggioritario funziona soltanto all’interno di un’unica comunità; se non v’è una condivisione dei principi sottostanti, non v’è nessuna ragione perché chi resta in minoranza accetti la decisione della maggioranza; e la nostra esperienza dimostra come «non si possano separare le procedure democratiche condivise da una qualche condivisione dei principi sottostanti».
A me sembra, d’altronde, che la convergenza di diverse ispirazioni ideologiche non abbia nociuto, nella prima parte della Carta costituzionale, alla coerenza della normativa che ne è derivata e del suo complessivo disegno ispiratore; ma, anzi, abbia costituito motivo di modernità e di dinamismo del prodotto finale: con una sorta di applicazione, ante litteram ed in progress, del metodo e del valore del pluralismo, che costituisce uno dei principi fondamentali della Costituzione.
La “forza ideale” della Costituzione (e quindi la sua attualità) si fonda proprio sull’adesione ad un’idea di democrazia pluralista, che supera la contrapposizione tra una democrazia formale di stampo liberale ed una sostanziale di stampo sociale; e sulla sostituzione del fondamento di autorità – o quanto meno sulla sua legittimazione – con un fondamento di valore, secondo un’etica repubblicana ispirata alla fusione tra la tradizione liberale, il solidarismo cristiano e le istanze egualitarie della sinistra.
Accanto a questa forza ideale – e proprio per garantirla nei valori di cui essa è espressione – la Carta costituzionale possiede anche una particolare “forza formale”, che si esprime nel suo carattere rigido. Ciò significa che le norme costituzionali sono sottratte, per esplicito dettato della stessa Costituzione (art. 134), alla abrogazione o modifica o deroga da parte della legge ordinaria. La rigidità non vuol dire certo immodificabilità; essa esprime, invece, l’auspicio che la modifica maturi, per quanto possibile, con la stessa coesione e convergenza di consensi che, a suo tempo, segnarono la nascita della Costituzione, per conservarle il carattere di “patrimonio comune”.
4. I frutti di questo pluralismo costituzionale si avvertono agevolmente, nella prima parte della Costituzione.
L’ispirazione personalistica, propria della componente cattolico-democratica, trova diretta espressione soprattutto nei diritti inviolabili dell’individuo, come singolo e nelle comunità intermedie (art. 2 Cost.; ma anche nell’affermazione di una comunità sovranazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni (art. 11); in quella delle confessioni religiose come organizzazioni sociali egualmente libere davanti alla legge (art. 8); in quella della libertà scolastica (art. 33) e assistenziale (art. 38) quali aspetti essenziali del pluralismo; nella concezione della famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio, luogo di esercizio di diritti e doveri tra i suoi componenti e all’esterno (artt. 29 e 30).
La prevalente ispirazione della sinistra socialista è segnalata dalla particolare attenzione ai profili dell’uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2), del diritto al lavoro e dei diritti del lavoro (artt. 4 e 35), del governo pubblico dell’economia (artt. 41 e 42), del ruolo dei partiti politici (art. 49).
Mentre l’intramontabile idea liberale della limitazione dei poteri dello Stato, nella quale il controllo reciproco è il presupposto della legittimazione e dell’indipendenza di ciascun organo, e dunque delle stesse libertà istituzionali, costituisce la chiave di volta dell’architettura del nuovo Stato.
Certo, la concreta attuazione di questi ultimi princìpi nell’ordinamento della Repubblica – nella seconda parte della Costituzione – costituisce il profilo meno adeguato del compromesso costituzionale. Qui il testo ha maggiormente risentito delle esperienze storiche e dell’opzione politica preferenziale per il Parlamento: sia per scongiurare il rischio di governi autoritari dopo il regime fascista; sia per contenere l’eventuale egemonia di una forza politica sulle altre. Sottovalutando la necessità di dotare i governi di adeguati strumenti operativi – una necessità resa sempre più urgente dall’interdipendenza delle economie e dalla partecipazione alle istituzioni sopranazionali, a loro volta dotate di concreti e diretti poteri normativi e di governo – questa parte appare più bisognosa di adeguamenti.
Non così la prima parte, dove non soltanto la nobiltà del compromesso, ma anche il coraggio di affermare diritti da alcuni ritenuti meramente programmatici – oggetto di critiche e ironie, accompagnate dalla definizione di Costituzione–programma, “libro delle possibilità” e “rivoluzione legale promessa”, più che catalogo di diritti esigibili – ha dato impulso e orientato gran parte della legislazione sociale successiva, per rimuovere gli squilibri e dare attuazione, ben oltre la proclamazione formale, ai diritti fondamentali, dal lavoro all’istruzione. La preoccupazione, poi, dell’articolo 3, secondo comma, al fine di garantire «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese», assume un significato quasi profetico se si considera il rischio, in un contesto di globalizzazione, di sacrificare la dimensione personale alle nuove e deformanti espressioni della realtà collettiva.
Le norme che a torto e riduttivamente si ritenevano da taluno meramente programmatiche, in realtà non soltanto rappresentano un vincolo per il legislatore; ma costituiscono altresì un parametro per il giudizio di legittimità delle leggi, anteriori o posteriori alla Costituzione, come la Corte costituzionale affermò fin dalla sentenza n. 1 del 1956. E vale la pena di richiamare le parole pronunciate dal presidente Napolitano nella celebrazione a Montecitorio, per sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalla giurisprudenza costituzionale (e togliere così il vicepresidente della stessa Corte dall’imbarazzo di doverne fare l’elogio, sia pure rivolto ai giudici suoi predecessori a Palazzo della Consulta): «La Corte Costituzionale – ha affermato il Presidente della Repubblica – ha svolto una funzione insostituibile, garantendo sia il rigoroso rispetto del dettato della Costituzione, sia la sua apertura a nuove realtà ed esigenze. Un’apertura consentita dalla sapienza dei costituenti, che condusse a formulazioni che lasciassero aperto l’adito all’accoglimento di significati non previsti né prevedibili al momento dell’emanazione della norma costituzionale». Un organo di garanzia, la Corte, che tanto aveva faticato per vedere la luce (a dieci anni di distanza dalla sua previsione nella Carta Costituzionale), a causa della diffidenza diffusa, a suo tempo, anche tra i partiti che avevano contribuito a quella previsione o almeno non si erano opposti ad essa; una diffidenza tuttora viva nelle critiche di ordine politico e nelle incomprensioni che talora accompagnano la attività della Corte, quale garante della Costituzione.
Accanto alle norme che definiscono obiettivi istituzionali e sociali per il futuro, ed a base di esse, i principi fondamentali posti dal Costituente a premessa della prima parte del testo. Sono «valori assunti a contrassegno della forma dello Stato», come li ha definiti Costantino Mortati; e non possono essere soggetti a modifica costituzionale, perché appunto «appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione», come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza 1146 del 1988.
I principi fondamentali della Costituzione non sono espressi per intero, né si esauriscono soltanto nei primi dodici articoli; essi richiedono un attento lavoro di analisi del testo costituzionale e si ricavano dalla sua interezza.
I princìpi fondamentali, inoltre, non si esauriscono nel sistema dei diritti e delle libertà fondamentali. Troppo spesso si è annullato il valore dei doveri sanciti dalla Costituzione, che non costituiscono soltanto l’aspetto speculare di molti diritti e libertà individuali, ma assumono una valenza istituzionale e politica di assoluto rilievo. Le istanze solidaristiche – proprie di una società che sulla libertà dal bisogno di ognuno e sull’eguale dignità di tutti trova forti motivi ideali di aggregazione; ed oggi più pressanti ed attuali che mai, di fronte alle macroscopiche sperequazioni, agli interrogativi e alle inquietudini nascenti dalla globalizzazione – possono sopravvivere solo con un senso complessivo del dovere, che accomuni sia i componenti della comunità statale, sia quelli delle comunità sopranazionali (si pensi, a questo proposito, al rilievo attribuito alla solidarietà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). Il valore ideale delle grandi democrazie occidentali sta proprio in questo: nel riconoscimento dell’altro come persona umana e soggetto di diritti, anche in ragione dell’accettazione di specifici e ragionevoli limiti al proprio catalogo di diritti individuali.
Fra i principi fondamentali, il principio democratico è quello di portata più ampia, che riassume gli altri. Quando, in Assemblea Costituente, fu posta ai voti l’espressione Repubblica democratica si registrò un’autentica unanimità di consensi, senza che vi fosse quasi discussione sul connotato primo della forma repubblicana, a dimostrazione che l’aggettivazione democratica contiene i fondamenti di libertà e di eguaglianza della Repubblica. Principio democratico significa, innanzitutto, che il potere politico deve promanare dalla collettività popolare, attraverso istituti che garantiscano sia l’esercizio diretto del potere (i referendum); sia la manifestazione di volontà di organi liberamente eletti (il Parlamento); sia il rispetto e la garanzia reciproci nel rapporto fra i vari poteri; sia il riconoscimento delle autonomie territoriali (già presente – ancorché tardivamente attuato – nel testo del 1947 e poi ridisegnato in modo ben più ampio dalla riforma del titolo quinto del 2001).
5. Dalla connotazione democratica origina quella lavorista, immediatamente e solennemente affiancata nell’articolo 1, a fondamento stesso della Repubblica. A chi ha ritenuto questa scelta un tributo eccessivo pagato all’ispirazione socialista, rispetto all’opzione per la dignità della persona e dei cittadini – presente in molte Carte costituzionali e anche in quelle sopranazionali, come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – basti ricordare che in tal modo la Repubblica ha voluto riconoscere che la dignità di ogni cittadino deriva non dal censo o dal privilegio, ma dalla sua libera scelta di un’occupazione adeguata e dal suo dovere di contribuire, attraverso il lavoro, al benessere collettivo e al concreto esercizio dei diritti fondamentali da parte di ciascuno. Il lavoro è inteso – secondo la sintesi efficace del Presidente del Senato Franco Marini, nella celebrazione del 23 gennaio scorso – come «mezzo di libertà, di identità, di crescita personale e comunitaria, di inclusione e di coesione sociale, di responsabilità individuale verso la società».
La grande portata e la perdurante attualità di una simile affermazione si coglie nel momento in cui precariato, lavoro nero e sommerso, elevati tassi di disoccupazione, ma soprattutto deficit di sicurezza nelle condizioni e in molti luoghi di lavoro – con un numero di incidenti e di morti (più di sessanta dall’inizio del 2008, e oltre mille l’anno in passato) degno di un bilancio di guerra e indegno di un paese civile – rendono assai problematico, ma proprio per questo ancor più importante, l’impegno assunto dalla Repubblica all’articolo 4 della Costituzione: riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuovere le condizioni per la sua effettività, in uno con il dovere per essi di partecipare con la propria attività al progresso sociale.
L’obiezione sull’opzione fondamentale per il lavoro è stata espressa anche in un altro senso: la Costituzione privilegerebbe il lavoro sulle libertà e proporrebbe una visione riduttiva della proprietà, dell’iniziativa privata e delle libertà economiche, collocate altrove e in posizione subordinata rispetto ai diritti fondamentali. Sarebbero così sottovalutate le esigenze di efficienza e competitività e del tutto trascurati il mercato e la concorrenza, solo recentemente e marginalmente richiamata dal nuovo articolo 117, a proposito della ripartizione di competenze legislative fra Stato e Regioni. Da ciò sarebbero derivati eccessi di statalismo e dirigismo, e la Costituzione sarebbe ormai inadeguata al quadro di valori proposto dai Trattati europei.
Queste critiche suscitano qualche perplessità, sia di merito che di metodo. Quanto al merito, appare evidente la possibilità di una lettura della prima parte della Costituzione più attuale e in certo senso più aperta alla prospettiva economica, proprio grazie alla sua formulazione. Lo ha dimostrato ampiamente l’articolo 11, con la sua capacità di accogliere, senza necessità di revisione, l’integrazione europea, partita proprio dal versante economico e della creazione del mercato e sempre più incalzante sul piano ordinamentale e istituzionale. Basti poi pensare, più in generale, all’ampiamente dimostrata capacità della Costituzione – anche grazie al già ricordato contributo della giurisprudenza costituzionale – di “coprire” adeguatamente valori ed esigenze non previsti esplicitamente al momento della sua elaborazione, come la privacy e l’ambiente.
Negli ultimi quindici anni la tutela della concorrenza e del mercato – per effetto della complementare normativa europea e interna, dell’indipendenza riconosciuta alle autorità di garanzia – è progredita in modo tale da far ritenere probabilmente non necessaria una revisione della Costituzione in chiave economica.
D’altronde, proprio nella prospettiva europea, invocata dai fautori di tale revisione, nel Trattato cosiddetto semplificato appena adottato a Lisbona, la Francia ha ottenuto di spostare il richiamo alla “libera concorrenza non falsata” in un protocollo allegato, sul presupposto che la concorrenza non sarebbe un obiettivo, ma uno strumento: e ciò per salvaguardare, almeno sul piano formale, la prospettiva del service publique, settore nel quale le recenti privatizzazioni e liberalizzazioni italiane, ancorché incomplete (ma per molti perfino eccessive) non sono affatto più timide della media dei paesi europei. Nella prospettiva italiana, poi, la recente giurisprudenza costituzionale – sollecitata dal riparto di competenze tra Stato e Regioni – ha affermato e sviluppato il tema della tutela della concorrenza, integrando il riferimento all’utilità sociale, posto dall’art. 41 come limite all’iniziativa economica privata.
Quanto al metodo, sono note le difficoltà emerse in occasione sia della riforma del 2001, confermata dal referendum popolare, sia di quella più ampia del 2005, annullata da analogo referendum popolare. Non solo una revisione di portata più generale, ma anche un intervento specifico e mirato su singoli punti appare problematico; il clima ed il contesto in cui si discute oggi della riforma costituzionale non sembrano tali da agevolare un intervento equilibrato, capace di rispettare la sintesi e l’equilibrio con cui, a suo tempo, si seppe esprimere la prima parte della Costituzione.
D’altra parte, nella legislatura 1996–2001, un disegno di legge costituzionale dell’allora opposizione di centrodestra, dedicato alla cosiddetta Costituzione economica, prevedeva la parziale riscrittura degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione per affermare esplicitamente i princìpi della libera concorrenza e del mercato, e per definire la proprietà privata un diritto fondamentale della persona. Si svolsero un’ampia indagine conoscitiva e un lungo dibattito in commissione, e l’esame fu sospeso in Aula perché il testo non era sostenuto dalla maggioranza dei parlamentari. Ma quando, nella legislatura successiva, il centrodestra divenne maggioranza e avviò la ben più ampia riforma della parte seconda, di Costituzione economica non si è più parlato e la modifica degli articoli 41–43 non è stata neppure riproposta.
6. Fra i principi fondamentali, l’art. 2 della Costituzione sancisce poi quello personalista, che ispira – come si è già accennato – il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo. La tavola di valori di tale concezione contempla non già l’uomo in funzione dello Stato, ma quest’ultimo in funzione dell’uomo. I diritti fondamentali della persona sono ad essa connaturati; non sono originati dall’attribuzione dello Stato; e riguardano tutti gli uomini, non soltanto i cittadini: constatazione, questa, di particolare attualità di fronte alla realtà e alle dimensioni dell’immigrazione, nella nostra società.
L’aggettivazione di inviolabili, che caratterizza tali diritti della persona, fu preferita a molte altre espressioni proposte in Assemblea Costituente (imprescrittibili, insopprimibili, fondamentali, essenziali, eterni, sacri, originari, naturali, incancellabili): l’inviolabilità si pone come entità indisponibile per lo Stato e, quindi, rappresenta un sicuro limite ad eventuali revisioni costituzionali che incidessero negativamente sui diritti dell’uomo.
La garanzia dei diritti individuali si estende poi alle singole formazioni sociali, destinate a sviluppare la personalità individuale. E’, questa, una delle espressioni più significative del principio pluralista della Costituzione, con il quale si garantisce la più ampia e incondizionata scelta dell’individuo nel creare, partecipare o non partecipare alle associazioni stesse, e nell’esprimere, in sostanza, la propria identità altresì attraverso il diritto al dissenso e alla diversità.
Anche qui le affermazioni del Costituente – al pari di quelle sul principio personalista – appaiono profetiche rispetto al momento in cui vennero poste, e sono particolarmente attuali in un momento (come quello che stiamo vivendo) in cui l’identità personale, anche di genere, è talvolta contrastata quando assume forme un tempo non previste e da alcuni non gradite; ovvero è minacciata da una dimensione globalizzante, che va ben al di là del mercato per coinvolgere la cultura, la vita sociale, il modo di essere liberamente scelto dai singoli e dalle aggregazioni sociali.
Il diritto alla diversità ed alla propria identità, in uno con la ricerca e la difesa di una gamma di diritti fondamentali inerenti alla condizione umana, da riconoscere nella loro universalità ed effettività, rappresentano un punto fondamentale del dibattito attuale sui grandi e inquietanti problemi posti dalla globalizzazione. Da ciò, dunque, la perdurante attualità, anche sotto questo aspetto di una Costituzione come la nostra, che si apre con l’affermazione del principio personalista e di quello pluralista.
La stessa attualità va riconosciuta anche, ovviamente, al principio di eguaglianza e di pari dignità sociale. Anzi, se v’è un momento in cui occorre riaffermare con forza il principio di dignità e di eguaglianza, è proprio questo inizio di secolo, che vede la dignità – a partire da quella “minima” nel vivere e nel morire – e l’eguaglianza offese in innumerevoli modi, i quali non hanno nulla da invidiare agli orrori e agli errori del passato; anzi, li sopravanzano per impiego di tecnologie e diffusione su larga scala.
Il principio di eguaglianza e di pari dignità introduce, innanzitutto, un limite alla discrezionalità del legislatore, tenuto a garantire trattamenti eguali per situazioni eguali e trattamenti diversi per situazioni diverse. Ma, accanto a tale contenuto precettivo di natura formale, quel principio impone alla Repubblica il compito di rendere effettiva la pari dignità sociale dei cittadini: un compito che si sostanzia in una serie di interventi di organizzazione politica, economica, sociale del paese, tali da rimuovere i fattori che impediscono la concreta realizzazione dell’eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana.
In ciò, l’art. 3 secondo comma, della Costituzione chiama ad un impegno strenuo e senza sosta. Ed è, questo, uno degli aspetti più dinamici della sua modernità, il quale salda strettamente fra di loro i principi di eguaglianza sostanziale e di pari dignità sociale con quelle di solidarietà: perché le differenze fra di noi sono oggettive e innegabili, ed anzi costituiscono premessa del pluralismo e del diritto alla diversità; ma non possono e non devono divenire condizioni di inferiorità. Per questo l’art. 2 – richiedendo l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ad integrazione del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo – salda strettamente fra di loro i diritti e i doveri, che ne sono la proiezione in termini di reciprocità.
Un ulteriore e fondamentale aspetto della tutela dei diritti fondamentali riguarda il passaggio dalla prospettiva nazionale a quella sovranazionale ed europea, valorizzando anche in questo caso l’attitudine profetica e la capacità di adattamento della Costituzione. Al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, si accompagna la rinuncia ad aspetti della sovranità nazionale a favore di realtà sovranazionali e comuni, per realizzare la pace e la giustizia.
Anche in questo caso si coglie agevolmente l’attualità dell’indicazione a suo tempo proposta dal Costituente, come reazione ad una guerra distruttiva da cui l’Italia era appena uscita; ed è un’attualità che si esprime in una duplice prospettiva.
Per un verso, il rifiuto di tutta la gamma di varianti escogitate – e recentemente riscoperte ed esaltate – per legittimare in qualche modo la guerra: quella per esportare la democrazia; quella per attuare l’ingerenza umanitaria, ben al di la delle operazioni di polizia internazionale; quella per esercitare una legittima difesa “preventiva”; quella per combattere gli “Stati-canaglia”, sostenitori del terrorismo; e così via.
Per un altro verso, l’accettazione della realtà unitaria europea e la sua assimilazione con l’ordinamento nazionale. Cinquanta anni di pace in una regione europea che era stata teatro di due guerre mondiali; la realtà di un mercato unico e di una moneta comune, e quella di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia; il riconoscimento dei diritti fondamentali in ambito europeo, arricchiti dai diritti c.d. di terza e quarta generazione; l’ingresso a pieno titolo della Carta di Nizza nei trattati europei, grazie al rinvio operato dal Trattato di Lisbona; la prospettiva di una cittadinanza europea che si aggiunga, senza eliminarla, alla cittadinanza nazionale: sono tutti aspetti che si reggono – per il nostro ordinamento – sulla preveggenza dell’articolo 11 della Costituzione. Una mirabile capacità di adattamento, ora completata dal nuovo testo dell’art. 117, primo comma, che impone al legislatore statale e regionale il rispetto “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
7. Nel ricordato contesto internazionale dell’immediato dopoguerra, la seconda parte del compromesso costituzionale – quella dedicata all’ordinamento statale – scelse inevitabilmente una prospettiva fortemente garantista, di equilibrio fra i poteri, affinché – con le parole di Leo Valiani – «la vittoria degli uni non potesse in nessun caso comportare la scomparsa degli altri».
I partiti politici, come si è visto dianzi, avevano svolto un ruolo fondamentale e insostituibile nel processo di fondazione dello Stato democratico e nella sua legittimazione, contribuendo – dopo la partecipazione alla Resistenza e alle guerre di liberazione – al “compromesso costituzionale alto”, in un contesto di estrema difficoltà: il crollo del fascismo, la debolezza del governo e dello stato; l’occupazione militare e la lotta di classe nel Nord del paese; la guerra fredda ed i conseguenti irrigidimento e contrapposizione dei blocchi internazionali, dopo Yalta. In questo contesto, con un paese inserito nell’area di influenza occidentale ed un forte partito comunista legato invece all’area di influenza orientale – pur in presenza di oggettive difficoltà per la realizzazione di un’alternanza democratica – i partiti riuscirono comunque a superare il conflitto fra istanze contrapposte di mutamento radicale o evoluzione graduale, di riformismo o garantismo; e ad assicurare la continuità dello Stato, a realizzare una democrazia socialmente avanzata, a promuovere il grande processo di integrazione politico–sociale del dopoguerra.
Il ruolo dei partiti – ha osservato recentemente Giuliano Amato – fu essenziale perché «c’era da una parte un insieme di ceti molto diffidenti verso la democrazia e in realtà ancora legati al precedente regime e c’erano dall’altra parte ceti proletari i quali vivevano quella stagione come prodromica a una possibile rivoluzione»; e «i maggiori partiti di quegli anni servirono ad innescare questi ceti nel sistema democratico, a farglielo progressivamente accettare».
Come disse Giorgio Amendola, furono i partiti, allora, la vera garanzia delle istituzioni: e quanto vorremmo che ciò fosse ancora vero. Peraltro, il compromesso costituzionale raggiunto non evitò la diffidenza fra le maggiori forze politiche, e le indusse a rinunziare agli strumenti per rafforzare il potere esecutivo: cioè a quelle “razionalizzazioni” che, secondo l’ordine del giorno Perassi in Assemblea Costituente, avrebbero dovuto accompagnare la scelta del governo parlamentare invece di quello presidenziale, per assicuragli una maggiore stabilità.
Da ciò – come osservava Roberto Ruffilli – la degenerazione dell’originaria supplenza istituzionale, svolta dai partiti, nella progressiva occupazione delle istituzioni, definita da Leopoldo Elia “l’occupazione del potere”; la progressiva conflittualità e paralisi del sistema politico, con il proliferare di partiti e formazioni, sempre più in crisi di legittimazione e identità.
In questo nuovo contesto, gli obiettivi da molti giustamente invocati per il nostro sistema politico–istituzionale – stabilità, governabilità, partecipazione, rispetto della volontà popolare – suggeriscono una serie di modifiche, per superare le rigidità e integrare le lacune della seconda parte della Costituzione. Vengono cioè in considerazione gli inconvenienti legati ad un bicameralismo perfetto e perciò pletorico; la opportunità di riconoscere al Senato funzioni diverse da quelle della Camera, a garanzia della rappresentatività e dell’equilibrio territoriale; la necessità di evitare il rischio di degenerazioni di tipo assemblearistico; ancora, la necessità, di garantire all’esecutivo e al premier la possibilità di esercitare il diritto-dovere di attuare il programma di governo; infine, la necessità di ovviare all’inefficienza derivante dalla farraginosità delle procedure decisionali.
Ma questa revisione, sicuramente opportuna e probabilmente necessaria, dovrebbe essere perseguita in modo laico, rinunciando alle contrapposte tentazioni di imbalsamare e blindare il testo attuale della Costituzione o, al contrario, di modificarlo a ogni cambio di maggioranza: e ciò proprio per evitare la tentazione di una dittatura della maggioranza, o il rischio di distruggere il “patrimonio comune”.
E giustamente si è suggerito di ripensare anche le procedure e le maggioranze richieste per la revisione costituzionale, e di considerare il legame insopprimibile fra riforma costituzionale e sistema elettorale. Sistema, quest’ultimo (com’è ben noto) volutamente sottratto alla prescrizione costituzionale, ma non per questo esente da obblighi di coerenza, ragionevolezza, pieno rispetto delle prerogative attribuite al sovrano, cioè al popolo, ultimamente considerato invece il notaio di decisioni assunte in luoghi ristretti, ovvero il campione – nel senso statistico e perciò altrettanto ristretto del termine – che esprimerebbe la sua volontà attraverso i sondaggi. Con l’effetto – non certo attribuibile soltanto al sistema elettorale – di accrescere «in modo preoccupante (la) distanza che separa i cittadini dalla vita pubblica, dalla politica e dalle istituzioni», come ha osservato Fausto Bertinotti nella celebrazione del 23 gennaio scorso nell’aula di Montecitorio: «Colmare questa distanza – ha aggiunto il Presidente della Camera – rappresenta il presupposto necessario per la risoluzione dei numerosi elementi di criticità con cui si confronta la comunità nazionale, in un’epoca di grandi cambiamenti densi di problemi molto ardui e assai dolorosi».
Con fatica e non senza incertezze, fino allo scioglimento delle Camere, le Commissioni Affari costituzionali dei due rami del Parlamento avevano ripreso ad occuparsi proprio di questi temi. Oggi incombono altre urgenze, altrettanto importanti per la nostra democrazia, e non so quanto sia concreto ed attuale, in questo momento, l’augurio con cui mi sarebbe sembrato logico, sino a qualche tempo fa’, concludere la riflessione sui sessanta anni della Costituzione: che il dibattito sulla riforma non sia il pretesto per mettere in discussione l’intero impianto costituzionale; che la riforma si realizzi con uno spirito costruttivo e di coesione pari a quello dei lavori dell’Assemblea costituente. Uno spirito mancato, tra le forze politiche, sia nella riforma incompiuta, che venne respinta con il referendum del 2006, sia in quella compiuta del 2001: con la conseguenza, fra l’altro, di scaricare sulla Corte Costituzionale un compito di supplenza non certo agevole.
E tuttavia, proprio questo dimostra come gli interventi sulla seconda parte della Costituzione – di fronte alla sua parziale inadeguatezza sopravvenuta – debbano saper coniugare la maggiore efficienza con le garanzie costituzionali e l’equilibrio tra i poteri, che quella parte della Costituzione ha comunque assicurato in questi sessanta anni. E dimostra, altresì, come la prima parte della Costituzione vada tuttora rispettata, per il suo valore e per la sua profonda vitalità: impegnandosi innanzitutto a conoscerla, e poi a darle effettiva ed integrale attuazione, prima di avventurarsi a dibattere sulla possibilità di una sua modifica.