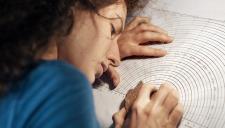Antonio Tabucchi è stato alla Normale venerdì 23 maggio. Ospite dei Venerdì del Direttore, ha tenuto una conferenza dal titolo Il filo dell’inquietudine: un percorso attraverso la letteratura del Novecento.
Inizia con un ricordo la conferenza di Antonio Tabucchi, ospite dell’ultimo appuntamento dei Venerdì del Direttore stagione 2007/2008. Lo scrittore parla del piacere del ritorno per il suo essere di nuovo a Pisa, di nuovo alla Normale, di nuovo nell’ambiente che ha accompagnato parte dei suoi studi nella cornice di una città deserta, estiva e lui a fare ricerca, fra i manoscritti e i microfilm che gli venivano recapitati da tutto il mondo.
Poi introduce il tema dell’incontro: il filo dell’inquietudine nella letteratura del Novecento, come spinta emotiva e allo stesso tempo creativa. E iniziano le citazioni, i nomi, le storie, il filo rosso che parte da Pessoa e si attorciglia intorno alle storie di vita e alle pagine di Rimbaud e di Walser.
L’inquietudine si fa estraneità, converge in quella sensazione di chi si sente straniero dovunque, diventa una forma di spleen baudeleriano e da snervamento si fa disagio. Il male di vivere, quello spesso incontrato da Montale. Una parentesi freudiana si apre nel contesto letterario: Tabucchi ricorda Freud e quella sensazione di non essere mai a casa, di non sentirsi mai adatto, a posto con quello che sta intorno. È il tempo della prima guerra mondiale e c’è un mondo che sta per scomparire, sotto le macerie e i detriti. La carneficina della grande guerra si porta via anche le certezze, la quiete. Quiete che si contrappone al filo dell’inquietudine che nello stesso tempo, però, prende le distanze dall’atteggiamento chiassoso di un Martinetti che incita al massacro delle trincee.
Arrivano i tempi di Orwell, Celine, Pessoa, Kafka e poi il dopoguerra, con il dubbio sulle legittimità dello scrivere ancora. Se lo domanda Primo Levi: si può scrivere ancora poesia dopo Auschwitz? Risponde Tabucchi: si deve scrivere su Auschwitz. Il problema è tutto in un avverbio. I personaggi di Camus e di Beckett tornano nel secondo dopoguerra a portare sulla pagina il senso di disaccordo con il reale e di estraneità a se stessi che in Italia vengono narrati da Volponi, Manganelli, Sciascia, che adotta la metafora della Sicilia, fino a Pasolini.
Qui, nella molteplicità di autori che varrebbe la pena citare – molti nomi, momentaneamente trascurati, vengono riscattati in seguito dalle domande e dai commenti del pubblico – la scelta tocca a Tabucchi, che si concentra su Pier Paolo Pasolini e Carlo Emilio Gadda. Riguardo a quest’ultimo Tabucchi arla di deflagrazione del linguaggio, che si fa in mille pezzi per rendere la coscienza infelice del paese Italia, specialmente quella di chi, come Gadda, auspica ancora l’onestà della borghesia colta ed intelligente che non c’è più, l’etica che rispecchia i grandi principi di un nazionalismo passato.
(sw)