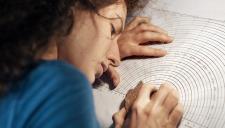La taliatina, quello sguardo mezzo di traverso che torna tanto spesso nella mimica del Commissario Montalbano, è stata alla base del sodalizio tra Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri. Lo scrittore siciliano ne ha parlato durante un seminario organizzato dal prof. Silvano Nigro.
Leggi la trascrizione dell’intervento di Camilleri
di Serena Wiedenstritt
La storia del rapporto fra i due scrittori siciliani è la storia di «un’amicizia del secondo girone» dice Camilleri all’inizio del suo intervento, che presenta come «una sorta di consuntivo dei nostri contatti e delle nostre collaborazioni». L’autore precisa :«Non rientravo nella prima cerchia di amici stretti di Leonardo, quelli che potevano chiamarlo affettuosamente Nana, come facevano Elvira ed Enzo Sellerio, il fotografo Scianna, il pittore Guttuso. Piuttosto mi spettava un posto nella seconda cerchia di amicizie, quella più diffusa e che aveva meno confidenza con lui».
Questo non ha impedito che si sviluppasse una frequentazione intensa con l’autore del Giorno della Civetta e dell’Affaire Moro: così le tappe condivise della loro carriera, gli incontri e le conversazioni diventano un romanzo nelle parole di Camilleri, che, davanti ad un’aula piena, alterna italiano impeccabile ed espressioni siciliane e induce il pubblico ora alla risata, ora alla riflessione e all’emozione.
«La storia dei nostri rapporti è iniziata con due occasioni mancate: la prima volta che contattai Sciascia fu quando lavoravo alla Rai, gli mandai una lettera in cui gli chiedevo di scrivere il soggetto per uno sceneggiato, ma lui rifiutò, disse che non se la sentiva» ricorda Camilleri. «Il secondo contatto arrivò poco dopo, quando fui chiamato dal Teatro Stabile di Catania a lavorare alla riduzione teatrale de Il Giorno della Civetta. Conobbi così Leonardo Sciascia, lui lesse parte dei miei scritti, una delle sue taliatine mi suggerì che ne era piuttosto soddisfatto, ma a causa dei ritardi di un altro teatro non riuscii a portare in scena la mia riduzione».
L’occasione per una reale collaborazione arriva qualche tempo dopo, quando Camilleri si trova a trasformare un breve racconto di Sciascia in uno sceneggiato televisivo: «Quando gli chiedevo un parere, Leonardo si limitava a rispondere con la solita battuta di verghiana memoria: quello che è scritto è scritto. Alla fine però mi disse che ne era venuta fuori una bella cosa e usò la metafora di un buon brodo tirato fuori da un dado Liebig, sottolineando come il buon risultato non fosse scontato, perché anche con un Liebig si può fare una schifezza di brodo».
L’amicizia fra Sciascia e Camilleri continua sulla scia delle conversazioni che trattano da Manzoni alle novelle di Pirandello, «che per entrambi erano più interessanti da mettere in scena delle stesse opere teatrali», da come Stendhal si sarebbe trovato a suo agio nell’Italia della Prima Repubblica fatta di corruzione e scandali al diverbio con Guttuso durante il sequestro di Moro. Sciascia è anche l’artefice dell’incontro fra Camilleri e la casa editrice Sellerio, fondata da Enzo ed Elvira Sellerio, con il supporto e la passione dell’autore siciliano. Fu proprio ad Elvira Sellerio che Sciascia presentò Camilleri proponendo la pubblicazione di La strage dimenticata, da lui definito bonariamente un saggio in siciliano. «Del resto la diversità fra i nostri linguaggi è profonda come quella che passa fra un bisturi, la lingua raffinatissima, lucente e tagliente di Sciascia, e un bastone da contadino, solido e nodoso come il mio modo di scrivere», spiega Camilleri.
Ma oggi, a diciassette anni dalla scomparsa del grande autore, cosa rappresenta Sciascia per Camilleri? «Una ricarica -dice il padre di Montalbano – quando mi sento stanco, quando mi manca l’ispirazione per scrivere, mi basta aprire una pagina a caso da un libro di Sciascia per ricaricarmi». Così, alla fine del seminario si fondono le due immagini: Sciascia che bofonchia in una nuvola di fumo, Camilleri che, nel suo studio e immerso nella stessa nuvola di fumo, si ricarica con una pagina di Sciascia. Nel mezzo una taliatina d’intesa.
Trascrizione dell’intervento di Andrea Camilleri il 15 dicembre alla Normale di Pisa.
di David Ragazzoni
Oggi non parlerò di Leonardo Sciascia autore, ma dei miei rapporti con Sciascia negli anni, i miei incontri con lui. L’inizio dell’amicizia – poi chiarirò di che grado di amicizia si tratta con Leonardo – inizia con due occasioni mancate, proprio tranquillamente fallite: ho usato la parola “amicizia” perché è bene che prima di tutto chiarisca in che grado lo fummo. Sciascia aveva una ristretta cerchia di amici di vecchia data, alcuni compagni d’infanzia, Guttuso, Consolo, il fotografo Scianna ed Elvira Sellerio. Molti di questa ristretta cerchia lo chiamavano “Nanà”, che è un diminutivo di “Leonardo”; poi c’era una cerchia più vaga, di quelli che lo chiamavano “Leonardo” o “Leonà”: io appartengo a questa seconda cerchia più larga. Da noi, come ovunque, l’amicizia comporta anche un certo grado di intimità, che in realtà tra me e Leonardo non ci fu mai.
La prima volta che entrai in contatto con lui lavoravo all’Ufficio ricerche e sperimentazione della RAI, che era diretto da Angelo Guglielmi, e c’eravamo inventati un programma, “Candid Camera”, e l’avevamo proposto alla direzione generale, avevamo fatto il numero zero di questo programma ed era piaciuto tantissimo tanto che avevano deciso di realizzare questo programma che poi divenne in realtà famoso. Allora, forti di questo successo, decidemmo di allargarci, come si dice a Roma, e quindi dice Angelo: “Perché non ci facciamo venire in testa un bel romanzo sceneggiato – come si usava all’epoca – ma, invece di trarlo da un classico o da un romanzo notissimo, lo facciamo ex novo (cioè su un soggetto originale)? ”. Io ci pensai e mi venne in mente il processo Notarbartolo. Questo Emanuele Notarbartolo, all’inizio del secolo Presidente del Banco di Sicilia, era stato assassinato in treno tra Messina e Palermo, chiaramente da dei mafiosi: si cominciava a delineare quell’intreccio tra banche, mafia e politica perchè di essere il mandante dell’omicidio venne accusato l’Onorevole Salvo Palizzolo. Quindi all’inizio del secolo già c’era tutto quello che noi oggi troviamo sulle pagine di cronaca. L’Onorevole Palizzolo, dopo anni di processi, in un processo svoltosi a Firenze venne assolto, direi inevitabilmente assolto, e accolto in Sicilia al suo ritorno con una manifestazione che poteva equivalere alla festa del santo protettore nei paesi, con la banda. L’idea piacque molto a Guglielmi, e fu lui che mi rispose: “Sciascia è disposto a scriverci una storia”. Il mio primo rapporto con Leonardo Sciascia è su carta intestata Rai; dandogli del Lei gli dissi: “Caro Sciascia, Lei sarebbe disposto a passare una quindicina di giorni?”, e Leonardo mi rispose dicendo: “Non me la sento, tutto questo mi porterebbe via troppo tempo. Se vogliamo fare una cosa seria, cercare i documenti d’archivio, gli atti del processo…”, controbattei: “Saremmo disposti a pagare noi una persona ai suoi ordini che vada a fare le ricerche per conto suo”, ma non se la sentì, e questa fu la prima occasione mancata.
Nello stesso anno il direttore dello stabilimento di Catania Mario Giusti mi chiamò per fare la regia della riduzione teatrale de “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, naturalmente io accettai battendomi il petto: “Domine, non sunt dignus”, figuriamoci fare la regia di questo testo, per me era come un sogno, e in quell’occasione, siccome la realizzazione era affidata a Giancarlo Sbragia, che era un attore bravissimo ma anche un sceneggiatore e un fine intenditore di letteratura , Giancarlo mi telefonò a Roma: “Puoi venire a casa? Vorrei leggere le prime scene che ho scritto”, e allora lì, andando a casa di Giancarlo Sbragia conobbi Leonardo Sciascia. Giancarlo cominciò a leggere quello che aveva scritto. Leonardo non reagì mai, a volte in una nuvola di fumo – lo dico io che fumo 70 sigarette al giorno – ogni tanto “eh, ehn, mm”, perché allora lui “bofonchiava”, ancora non aveva il dono della parola, aveva già lo splendido dono della scrittura, poi imparò a parlare, certo un po’ male, con fatica, rifiutandosi di parlare – credo che il suo ideale fosse quel personaggio de “Le bugie” di Edoardo de Filippo, quello che dice “Che parlo a fa’?” e parla solo con i razzi luminosi, ed è arrabbiato o allegro a seconda del colore del fuoco luminoso.
E alla fine giustamente Giancarlo disse: “Che ve ne pare?”, e Leonardo riuscì a “murmuriare” – si dice in Sicilia – qualche cosa che capii come: “Gli è piaciuto?”, “Sì”, “Come fai a dirlo?”, “Perché me l’ha detto,” “Come te l’ha detto?”, “Con gli occhi”, perché guardandomi approvava con gli occhi. Ora devo dire che questo poi è stato uno dei mezzi di comunicazione fondamentale tra me e Leonardo Sciascia, la “taliatina”. Mia moglie, che non è siciliana, però ha imparato molto, un giorno che eravamo in una stanza (quattro persone più Leonardo Sciascia), colse al volo una taliatina tra me e Leonardo e scoppiò in una risata irrefrenabile, insieme agli altri che non capivano, perché in realtà aveva colto il senso di quella taliata tra me e Leonardo in rapporto a un discorso assurdo di un tale.
Allora capitò che io in quei giorni stavo mettendo in scena a Palermo un altro dei miei testi preferiti, “La favola del figlio cambiato” di Pirandello, e così passavo interi pomeriggi con Leonardo a Palermo per parlare del copione che intanto Giancarlo aveva finito e ci aveva consegnato. Una serie di circostanze incredibili mi costrinse a rimandare di quindici giorni la messa in scena de “La favola del figlio cambiato” a Palermo, per cui quelli di Catania vennero da me e mi dissero: “No, allora la regia la fa un altro”, e dovetti a malincuore rinunciare. La seconda occasione mancata.
Ma durante quei pomeriggi certo non parlavamo solo della sua riduzione, ma anche di altro e ora ci arrivo, ma prima devo dire un’altra cosa.
L’anno dopo il Teatro Stabile di Catania mi chiese di mettere in scena un lavoro. Io andai in scena con questo lavoro e la sera della prima mi dissero: “C’è Leonardo Sciascia in sala”, alla fine lo incontrai nella hall del teatro quasi casualmente, mi disse: “Bello spettacolo”, “Grazie”, “Hai preferito fare il lavoro di un settentrionale piuttosto che il mio”.
Allora, parliamo del “lavoro del settentrionale”. Il “lavoro del settentrionale” era il risultato di una cosa che ebbi a constatare nei numerosi incontri palermitani con lui. Cerano già naturalmente molti giovani scrittori o non giovani scrittori che gli portavano manoscritti per avere un suo giudizio. Lui li leggeva accuratissimamente e poi, se ci trovava qualche cosa di buono ne era felice; se invece c’era poco da essere felice, cercava di rendersi felice, si arrampicava sugli specchi pur di poter dire: “Beh… ma insomma… potresti rimetterci mano…”. Era di una crudeltà estrema, impietosa nei riguardi di un autore nato da Roma in su, spaccava il capello in quattro: “No…guarda Camillè, guarda che non è così…perché io degli autori siciliani voglio essere il padre, l’amico, il fratello, il complice… Davanti a un autore siciliano divento mafioso”. Allora mi venne da ridere, ma credo che avesse perfettamente ragione, perché un po’ lo sono diventato anch’io. E quando io gli dissi: “Non ti sembra eccessivo?”, mi rispose: “Ti dico la verità assoluta: difendi il tuo uomo a torto e a ragione”, quindi lui considerava suoi gli autori siciliani, suoi, cosa sua, per amore. E questa è l’altra bella lezione che ebbi da lui.
L’altra cosa che volevo dirvi è che, quando stavo scrivendo “Un filo di fumo”, mi era venuto in mente di far affondare la nave in una secca che prima era stata un’isola, l’isola Ferdinandea, ma non riuscivo a trovare nessun elemento sull’isola Ferdinandea. Un giorno lo incontrai a Roma, gli dissi: “Leonardo, senti, se hai qualcosa sull’isola Ferdinandea, c’è un libro o qualcosa che posso trovare?”, mi rispose: “Vai in questa libreria antiquaria; appena entri, c’è uno scaffale grosso, poi ce n’è un altro, dopo, più piccolo, sul terzo ripiano c’è un volumetto così, che si chiama “L’isola Ferdinandea, con la copertina marrone, del Geometra Gemellaro….”. A memoria. Aveva la collocazione del libro in testa.
Capitò poi che io sceneggiai un suo racconto per la televisione, e questo è stato un bel problema. Era un raccontino di tre pagine, che s’intitolava “Western di cose nostre”. Era pubblicato nella raccolta “Mare colore del vino”, tre pagine erano. E io dovevo cavarne fuori tre ore di trasmissione televisiva, e c’erano cose che dovevo inventarmi di sana pianta. Ora, io avevo paura avevo paura a inventarmi di sana pianta. “Leonà, secondo te sarebbe opportuno?”. La risposta era immancabile, il fesso ero io che continuavo a insistere, era una risposta verghiana: “Quello che è scritto è scritto”, che è la risposta che Verga dà a Pirandello quando Pirandello parla di Verga in presenza di Vrga e Verga alla fine gli dice: “Caro amico, voi avete detto delle cose meravogliose ma…quello che è scritto è scritto”. Quindi io andai avanti un po’ alla cieca, un po’ timoroso. Questa cosa andò in onda, tre puntate, ebbe molto successo, e io volevo il suo giudizio. Allora, c’è stato un giornalista che ci fece una sorta di intervista a distanza, “Questo racconto è talmente concentrato, che basta scioglierlo in un po’ d’acqua e se ne fanno tre puntate”.
A proposito di buon brodo, proprio una settimana dopo che eravamo andati in onda con questo sceneggiato, mi invitò a pranzo nella sua bella casa di Palermo. Alla fine, essendosi lui un attimo assentato, no, lui presente, alla Signora Maria, la moglie, dissi: “Davvero una cuoca straordinaria! Grazie per questo pranzo straordinario!”. Poi lui si alzò, se ne andò di là e la Signora Maria mi disse, a bassa voce: “E’ lui che ha cucinato, stamattina si alzò alle sei per cucinare, non vuole che si sappia…”.
Io feci poi con lui una trasmissione importantissima, che non so se esiste ancora registrata, faceva parte di un ciclo, “Uno scrittore e la sua terra”. Io facevo una scaletta di domande da rivolgere a Sciascia, e due giornalisti – uno francese e l’altro inglese – rivolgevano le domande a Sciascia che rispondeva sul suo rapporto con la Sicilia. Sono quattro trasmissioni di tre quarti d’ora ciascuna. Durante queste trasmissioni, capitò l’incidente con Guttuso. Con Guttuso erano amici eterni, era stato Guttuso a convincerlo a candidarsi alle comunali a Palermo, e si era presentato come indipendente. Ma durante il sequestro Moro, Guttuso propose un giorno a Sciascia di andare a trovare Berlinguer, e lo trovarono distrutto, perché Berlinguer, a parte la tensione di quei giorni, pensava che dietro il sequestro Moro, oltre alle Brigate Rosse, ci fosse una felice congiunzione tra CIA e KKB, proprio per evitare la svolta a sinistra che si sarebbe fatto con l’appoggio esterno dei comunisti al governo democristiano. Leonardo pensò bene di scrivere l’articolo sul “Corriere della Sera” su posizione timori e dubbi di Berlinguer. Berlinguer, ancora legato a Mosca, non poteva accettare e smentì, disse: “Sciascia non ha capito bene”, e mentre Sciascia si lasciava dire “Non ha capito bene”, mi disse: “C’era presente Guttuso”. Guttuso, membro della direzione del Partito Comunista, non poteva smentire il segretario: “Forse non ha capito bene”, e da questo momento si ruppe una bella amicizia. Io: “Leonà, hai sbagliato a tirare in ballo Guttuso”. Una belva: “Se è un amico, lui doveva fare la parte dell’amico!”, “Leonà, se eri amico non dovevi tirarlo in ballo sapendo la sua posizione”. “Tu lo difendi perché sei della stessa maledetta parrocchia di Leonardo Guttuso”. E queste erano le nostre discussioni politiche, che a volte raggiungevano toni non indifferenti. Ma l’amicizia rimase sempre immutata.
Parlavamo di Manzoni, Stendhal… “Voi registi – mi disse un giorno – non fate altro che leggere e mettere in scena il suo teatro, e trascurate quella miniera che sono le novelle al cui confronto il teatro diviene una cosa che sa di artificiale”. Un giudizio che ho finito quasi con condividere dal momento che ho messo in scena la serie di novelle di Pirandello. Un giorno dissi: “Chissà come si sarebbe trovato Stendhal in Italia ai giorni nostri?”. Si sarebbe trovato da Dio: quanti bei corrotti, quanti bei brigati e scandali…! Sarebbe stato felicissimo, Stendhal, di essere ai nostri giorni.
La cosa più importante che mi capitò. Io avevo sentito il racconto di una strage che era avvenuta nella torre di Carlo V nel mio paese, che era una torre difensiva e poi un carcere coi Borboni e tale era rimasto. Nel 1848 si diceva che durante le insurrezioni il comandante dei carcerati rinchiusi nella torre, temendo un’insurrezione e l’appoggio della gente esterna, li fece ammazzare in una notte: 114. Però non se ne trovavano i corpi. Una leggenda paesana. Un mio amico fiorentino riuscì a trovare il registro dei morti del 1848 e c’erano, a parte, 114 morti in una torre chiamati allora “servi di pena”. La cosa mi risultava vera. Presi questi documenti, invitai Leonardo Sciascia a prendere un caffè a casa mia a Roma. Arrivò a casa mia, iniziai a spiegargli la situazione, gli detti i documenti, gli dissi: “Leggi”, lui se li lesse, disse: “Posso venire a prendere un caffè?” e tornò; mi disse: “Mi sembra una cosa molto bella, molto singolare, bisognerebbe scriverla”, “Scrivila, ti ho portato intanto tutti i documenti x scriverla” “Perché non la scrivi tu?”, mi disse. “No, io non la saprei scrivere come la sapresti scrivere tu…”, “Io scrivo come so scrivere io, tu scrivi come la sai scrivere tu”, “Ma sai, Leonardo…io non ho mai scritto una cosa, ho scritto dei romanzi”, “Io ne scriverei un libello”, “Scrivilo tu invece”, e così io scrissi i “Saggi Dimenticati” e gliela diedi. “Io questa la porto a Sellerio”, e così gliela portò, e mi fece conoscere Sellerio, che è tutta un’altra storia a parte. Però quando la lesse disse: “Troppe parole siciliane ci sono”, “Leonà, ce ne sono di meno di quelle che c’erano in “Filo di fumo”, “Sì, ma “Filo di fumo” è un romanzo, questo è un saggio. Scrivere saggi in siciliano?”, “Leonà, non so scrivere diversamente”. “A te piace scrivere così perché?”, “Leonà – gli dissi – a te piace affilare il tuo italiano per farne una specie di bisturi, un prolungamento della finezza della tua ragione: questo è il tuo italiano. A me piace usare un italiano che è come quei bastoni dei contadini in cui si vedono i nodi del ramo da cui è stato cavato fuori, non so scrivere diversamente. Se vuoi le levo le parole siciliane”, “No – mi disse – volevo soltanto avvertirti”. Così diede queste 60 pagine a Elvira Sellerio, e fece una cosa che ho scoperto attraverso Salvatore Silvano Nigro in quel bellissimo volumetto dedicato a Sciascia editore, cioè “la revisione della bandella”, che è esattamente quello che volevo dire io con quel saggio.
Questi sono stati i miei contatti. Dirò altre due cose.
La prima è che mi chiese un racconto per la II seconda edizione dell’Antologia degli scrittori siciliani che aveva fatto con Guglielmino, “Però non voglio – mi disse – pagine di romanzo, voglio un racconto; se hai un racconto me lo dai”. Montalbano era ancora di là da venire, di racconti ne avevo scritti solo tre, gli dissi: “Te li do tutti e tre, tu scegli quello che ti piace”. Dopo un po’ mi telefonò: “Guarda Andrè, pubblicherò quello che si intitola “Capitan Cagi”, non lo dare ad altri, mi raccomando, perché quello lo voglio pubblicare io”. Non passano manco quindici giorni che mi capita tra le mani un romanzo di Jorge Amado, che si chiama “Storie del porto di Pavia”. Lo apro, lo vedo e allibisco, perché il mio Capitan Cagi è il protagonista del primo dei due racconti che costituiscono “Storie del porto di Pavia”. Non solo, ma gli capitano le stesse cose, almeno due cose gli capitano identiche. Ora vi racconto la prima, che è pazzesca come possibilità che due scrittori abbiano la stessa intuizione nello stesso tempo.
Capitan Cagi racconta che naufragano a Capo Horn, come è naturale naufragare a Capo Horn, e si trova su una zattera con un nero enorme che si chiama Baobab. Si rendono conto che i viveri sono troppo pochi fino all’arrivo di una nave che li salvi, e decidono di giocarsi la sopravvivenza a 3 7 e briscola, di mano in mano. Il nero perde e si butta in mare annegando, e Capitan Cagi viene salvato. Com’è che lo stesso episodio me lo trovo da Amado? C’è da impazzire a rifletterci, perché io non avevo letto prima questo racconto di Amado.
Mia moglie avanza un’ipotesi, è una storia di mare che probabilmente tanto Amado quanto io abbiamo sentito. Dovetti telefonare a Leonardo Sciascia e dirgli: “Non ti posso dare “Capitan Cagi””, “Perché… “, gli dissi perché. “Capita, non resto per nulla sorpreso”. “Come capita, Leonà?!”, “Capita”. E infatti, un mese, due mesi dopo mi capita di leggere su “Repubblica” un articolo di Italo Calvino, che sta recensendo un’antologia di racconti fantastici italiani del ‘900, e dice: “Ce n’è uno di un autore siciliano che andrebbe veramente rivalutato, Beniamo Ioppolo, il racconto s’intitola “Lo zio”. E’ la storia di una coppia di fidanzatini, il fidanzatino dice alla fidanzatina: “Madonna, ieri sera mio zio me ne ha detta una….!”. Racconta le storie di questo zio, ironiche, storielle divertenti, battute fulminanti. “Presentami tuo zio”, irrigidimento da parte del ragazzino: “No, non vuole vedere persone…”. A un certo punto il ragazzo è costretto ad allontanarsi dal paese per una quindicina di giorni, la ragazza scopre l’indirizzo dello zio, va alla porta, bussa alla porta dello zio, sente una voce all’interno che dice: “Avanti!”, entra…una foresta tropicale, c’è uno scimmione aggrappato a un albero che dice: “Tu devi essere la ragazza di mio nipote…”. Ecco – dice Calvino, solo che io ho scritto un racconto identico, intitolato “Lo zio”, solo che lo zio è un delfino nel mio racconto. Forse le idee narrative sono idee archetipali, che stanno lì in questa bella biblioteca archetipale, arriva uno che deve scrivere un racconto dice: “Scusi, mi dia questo volume”, lo piglia, scrive il suo racconto, lo rimette a posto, arriva lui, lo ripiglia e va a finire che coincide”. Io mi sono accontentato di questa bellissima spiegazione che mi piaceva tanto.
Volevo dirvi per ultimo che mi è capitata una cosa emozionante. C’è stato un periodo in cui la radio faceva le interviste impossibili, ripubblicate da Donzelli, non tutte, le interviste sono 84, loro ne pubblicano 82. Allora Leonardo Sciascia scrisse un’intervista a Maria, l’ultima regina borbonica. Allora lì era indispensabile che l’autore fosse anche l’intervistatore, ma lui all’idea che doveva parlare alla radio davanti a un microfono, fingere di essere se stesso, si rifiutò. Vent’anni dopo la Signora Maria mi disse: “Vogliono mandarla in onda, può fare la parte di Leonardo?”, e io così ho fatto la voce di Leonardo Sciascia in quell’occasione, un pochino emozionato, un pochino divertito.
Un’ultima cosa. Io sono stellarmene lontano da Sciascia, proprio come scrittura, mi pare sia evidente. Come esercizio della ragione riesco a mantener un’autonomia della ragione di circa dieci minuti, poi crollo in preda alle passioni, arrabbiature… Anche nella scrittura, non solo come fatto caratteriale. Però capita, non ora che ho 81 anni, anche vent’anni fa, capita di sentirsi le batterie scariche, “stamattina non ce la faccio a scrivere, a fare niente”. Io ho trovato un rimedio. Il rimedio consiste nell’aprire una pagina qualsiasi a caso di Leonardo Sciascia, che tengo sotto mano nel mio studio, e leggo, e quando ho finito di leggere quella pagina mi sento che le mia batterie si sono ricaricate. Ha la capacità, una pagina di Leonardo Sciascia, di farmi tornare vivo. Grazie